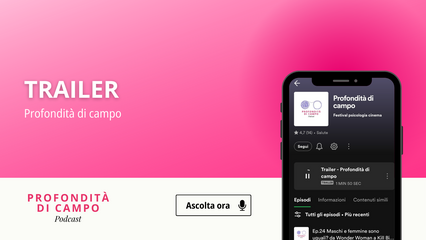C’è chi le aspetta per anni e chi le teme impaurita: piccole o grandi, giù o su, l’arrivo delle tette è qualcosa che non passa inosservato. Il seno è il carattere sessuale (secondario) che più di altri identifica socialmente l’essere nat3 in un corpo femminile, al pari della barba per un uomo. Questo è il motivo per cui il vissuto disforico di molti bambini e ragazzi trans si organizza proprio intorno alla percezione ed al rapporto con il seno. Ma è qualcosa che non riguarda scontatamente solo loro.
I caratteri sessuali biologici diventano psicosociali con grande rapidità. Mi torna in mente il racconto di una collega. La figlia preadolescente le confida di sperare che non le cresca il seno “grosso” perché teme che possa darle fastidio nel gioco. I giochi che appassionano questa bambina sono di abilità fisica ed intellettiva e, nei fatti, il seno – anche prosperoso – non sarebbe di grande impaccio, lo sarebbe però simbolicamente.
È l’esperienza raccontata da una paziente. Un ricordo di quando era piccola: nei giardini della scuola vedeva da una parte le bambine giocare con delle bambole e dall’altra i bambini giocare a calcio, palla avvelenata, ping pong su di un tavolo inventato. Lei, amante fin da piccola dello sport, era amica di tutti ma più spesso giocava con bambini perché si divertiva di più. Ancora non lo sapeva cognitivamente, ma forse lo sapeva emozionalmente, con quella scelta stava provocando un importante organizzatore sociale: il genere. Questo si presumeva essere a fondamento di differenze comportamentali e affettive pretese naturali come la competizione per i bambini e l’accudimento per le bambine. Tutto fila liscio fino a quando un compagno, durante il gioco, intravede un accenno di seno sotto la sua maglietta e le urla: “Ma tu hai le tette!” e lei, come fosse stata scoperta, piena di vergogna e paura balbetta qualcosa e se ne va. L’evento è raccontato come fondazione del suo interesse per la competizione sportiva della quale fece nel tempo una professione (inutile dirlo, in uno sport tradizionalmente maschile).
Il seno di una donna – diremo più avanti il corpo in generale - non è solo di quella donna, esce dai labili confini del privato per diventare sociale e politico. Quello fu il giorno in cui per quella bambina comparvero le tette, prima aveva un seno. Ma quand’è che i seni diventano tette?
Domanda valida sia per la storia individuale che collettiva. Sebbene oggi siamo piuttosto immersi in una pressante sessualizzazione del seno femminile, la sua eroticizzazione non è scontata se si osserva il fenomeno da un vertice storico. Si pensi alla Venere di Willendorf simbolo di forza legato al potere della Maternità e della Natura o la plurisenuta Artemide Efesia. Allora come adesso, il seno assume questa duplice valenza simbolica sacra e sessuale ed in entrambi i casi la soggettività di chi quel seno porta, viene ignorata. La bambina, scopertasi con le tette, non poteva più giocare con i suoi amici, era diventata potenziale oggetto di una relazione attrattiva e non più di scambio, un’amica con cui fare cose insieme. Quanto raccontato mi fa venire in mente la nota campagna #freethenipple. Siamo negli Stati Uniti, 2012. Attraverso il lavoro di Lina Esco, nasce il movimento Free the Nipple. Le attiviste coinvolte, attraverso proteste pubbliche in topless e una campagna on line, denunciano l’oggettificazione del corpo femminile che considera intrinsecamente sessuale – e quindi censurabile - il seno di una donna, differentemente da quello di un uomo. Potrei continuare ma la questione mi sembra delineata: il corpo è un soggetto politico e, in alcuni casi, ce ne accorgiamo più di altri. La reazione all’uso culturale della corporeità è stata, talvolta, negarne la valenza politica: “sono solo ghiandole appese”, leggevo in alcune pagine. A me piace l’idea di assumere tale valenza come premessa ineliminabile del rapporto con il corpo e con l’altro. Questo mi pare renda tutto più interessante.
La visibilità del corpo fisico e il suo divenire segno rappresentativo di culture è un fenomeno del quale non ci si può non occupare clinicamente. Siamo spesso portati a discutere di come faccia sentire vivere in corpi non conformi ai canoni estetici del momento, di come si abiti la marginalità quando assume la forma delle forme (perdonate il gioco di parole), a qualche deviazione standard dalla norma presunta. La bambina che scoprì giocando di avere le tette, con gli anni divenne una donna ed il caso – o qualunque cosa chiamiamo caso - volle che divenisse una donna bella secondo i canoni correnti. Si raccontava come stanca ed impaurita, vittima del pregiudizio della bellezza. Sentiva il peso e la responsabilità di un corpo in grado di sollecitare attrazione e desiderio, si sentiva presa dentro trame di rapporto fondate sul possesso reciproco e non era felice. Questo essere percepita come bella e attraente la faceva sentire anche poco interessante intellettualmente, le due cose si presentavano insieme, come inseparabili. Il mito della bellezza femminile sembrava escludere la possibilità di intessere relazioni interessanti con le persone. Il timore di essere vissuta solo come attraente diventava, come in una profezia che si autoavvera, inibizione e timore di parlare, ritiro sociale, rinuncia alla conoscenza del mondo. Ogni situazione sociale, dall’aperitivo con un’amica all’ingresso in un negozio, diventava tribunale di un processo al suo valore, la pressione era tale da vivere quei contesti con goffaggine e “timidezza”, come diceva lei. La sua bellezza “l’aveva resa timida”, aggiungeva.
Che il corpo abbia una valenza politica e che possa essere usato come tramite simbolico per nominare quello che proviamo è un’affermazione potenzialmente sempre valida. Come avviene questo processo nell’ignoto della soggettività di ognuno di noi è la sfida conoscitiva delle relazioni analitiche e terapeutiche in generale.
In questo caso prendemmo il filo rosso della timidezza per addentrarci in quell’ignoto. In un’occasione, dizionario etimologico alla mano cercammo la parola timida, parola satura e abusata nelle narrazioni autobiografiche.
Timido viene da timère, temere. Il vissuto di timidezza sembra abbia a che vedere con la paura. Cosa succederebbe se sostituissimo le due parole? Se invece di dire “sono timido”, ci dicessimo “sono intimorito”? Verrebbe subito voglia di fare una domanda in più, magari chiedere di che, quando, come. Questa donna trovò conforto nel ribaltamento delle asimmetrie di potere (legate alla bellezza) attraverso la competizione sportiva muscolare dove dimostrare di non avere paura di niente. Esaurita la funzione attribuita allo sport, l’interesse per esso scemò e rimase sola con la sua “timidezza” che ora possiamo chiamare paura.
E adesso poniamoci una domanda, che poi è la domanda per chi fa il mio mestiere: la paura è un’emozione provata di fronte ad un pericolo o è la paura stessa che costruisce il pericolo? Vi propongo qui delle osservazioni forse non mainstream se rapportate alla paura intesa come emozione primaria ed universale, quella di Inside Out della Disney per intenderci: la paura sembra esitare più che dalla presenza di una minaccia, dall’assenza di un generico stato di sicurezza interna. Questa assenza, questo vuoto, angosciante oltremodo, diventa un pericolo, atteso, anticipato, allucinato.
La bambina ha paura quando perde il seno inteso quale condizione di sicurezza e di reciprocità amicale con gli altri bambini. Le tette, simbolo di potenziale seduttività e attrazione, diventano minaccia pervasiva alla possibilità presente e futura di “giocare insieme”.
Questa minaccia alla possibilità è forse la cifra più annichilente della paura. Il lavoro psicologico qualcosa può fare ed è, sostanzialmente, nominare e pensare queste emozioni, collocarle nella storia individuale e sociale e restituire quel potere trasformativo che costituisce la nostra libertà così da continuare a giocare insieme, con meno competizione e più competenza.