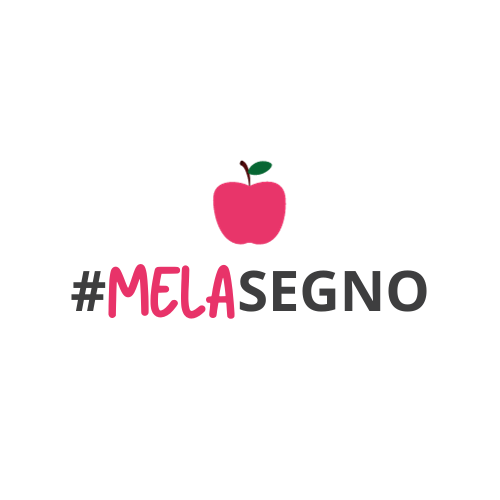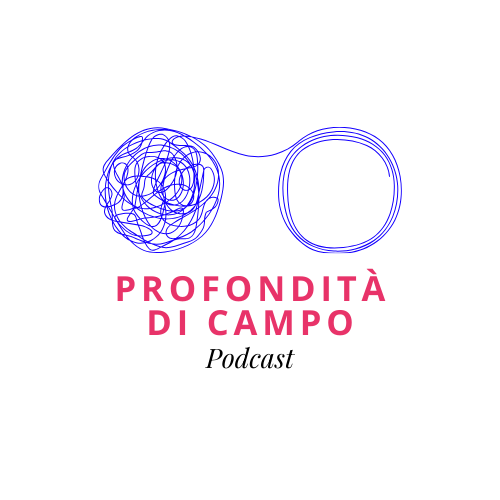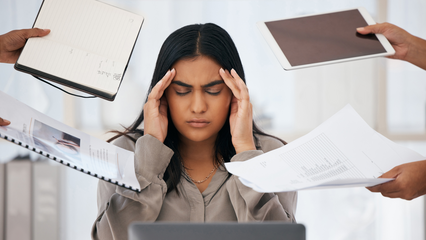Qualche tempo fa, una mia cara amica mi contatta per pormi una domanda molto specifica: “qual è il termine che definisce quei problemi psicologici organici a un comportamento funzionale? Ad esempio una convinzione sbagliata, magari frutto dell’educazione familiare, ma che ormai, per come ci si è sviluppati, tutto sommato aiuta a funzionare?”.
Lei si occupa di economia e studio dell’impatto che l’Intelligenza Artificiale avrà nei prossimi tempi sul sistema economico, ma anche dei suoi risvolti etici.
Inizialmente, la sua domanda mi fa pensare agli schemi di attaccamento appresi o ai modelli operativi interni. Quella serie di comportamenti, credenze, attese ed emozioni che, seppur disfunzionali, nel contesto familiare d’origine hanno permesso di sopravvivere e che dunque si sono sedimentati e vengono riproposti anche in età adulta, anche quando la loro funzione iniziale non è più confermata dalle nuove condizioni. Sono modelli relazionali che agiscono a livello inconscio e che informano su quali sono le reazioni che ci aspettiamo di ricevere. Se nel rapporto con il materno, ad esempio, essere accudenti verso il genitore si è rivelato vincente nella prima infanzia, tenderemo a riproporre con il nostro partner comportamenti accudenti, anche quando essi sono disfunzionali, perché portano via molte energie e non riceviamo altrettanto accudimento, di cui magari avremmo un profondo desiderio.
Tuttavia, la mia amica ha usato la parola “organico” e una parte di me comprende che sta cercando un altro termine nella sua memoria. Le rispondo che forse si riferisce a “egosintonico”. Un sintomo si definisce egosintonico quando è completamente integrato nell’Io, nella percezione di sé e non viene vissuto come problematico. Molti comportamenti compulsivi, ad esempio, sono egosintonici. La persona che li mette in atto non li vive come un problema, mentre il contesto esterno potrebbe percepirli come strani, inutili, eccessivamente ossessivi.
La mia amica conferma che è questa la parola che stava cercando. Un’immagine ha creato un nesso nella sua mente, la carta del sei di spade.
Le sei spade conficcate nella barca rappresentano un comportamento pericoloso, perché potrebbero farla affondare. I personaggi nell’immagine, nonostante ciò, continuano a navigare senza percepire il potenziale pericolo. Quelle sei spade sono egosintoniche rispetto al loro obiettivo, raggiungere l’altra sponda del fiume.
A questo punto, inizia lo scambio con ChatGPT, il sistema di intelligenza artificiale più conosciuto al grande pubblico. La mia amica chiede quale possa essere il nesso fra la carta e il termine egosintonico, ma lo chiede prima di tutto alla versione 3.5 del programma, ricevendo una risposta non soddisfacente. ChatGPT 3.5 si giustifica così:
“Certo, comprendo che la mia risposta potrebbe non essere stata esattamente ciò che desideravi perché "egosintonico" si riferisce più specificamente a comportamenti o pensieri che sono congruenti con la percezione di sé dell'individuo, piuttosto che a credenze che sono erronee ma funzionali in qualche modo. Il termine è più strettamente legato alla psicopatologia e alla psicoanalisi, dove viene utilizzato per descrivere l'accettazione o l'approvazione interna di pensieri o comportamenti che possono essere considerati clinicamente problematici. Se hai un altro termine in mente o se c'è un concetto più specifico che stai cercando di descrivere, sono qui per aiutarti a trovare la parola giusta!”
ChatGPT 3.5 si avvale ancora di un sistema interpretativo limitato. Appare come un professorino che si limita a valutare la correttezza delle nozioni, facendo riferimento a ciò che già sa - ciò che dunque gli è stato messo a disposizione sinora - in modo rigido.
La mia amica, ora, tenta con la versione più aggiornata del programma, ChatGPT 4.0:
“Analizzando la carta del 6 di Spade, un dettaglio particolarmente notevole è la presenza delle spade piantate sul fondo della barca. Questo aspetto è visivamente strano e potrebbe sembrare incoerente o addirittura pericoloso, visto che le spade potrebbero danneggiare la barca stessa, creando un rischio di affondamento.
Ricollegandoci al concetto di "egosintonico", possiamo vedere un parallelismo interessante qui. Le spade nella barca, pur essendo un elemento apparentemente dannoso o disfunzionale, sono accettate e non rimosse dai passeggeri. Questo può simboleggiare come alcuni comportamenti o tratti di personalità che sono egosintonici per un individuo possano sembrare irrazionali o dannosi agli occhi degli altri, ma sono mantenuti perché in armonia con il sé dell'individuo.
In questo modo, le spade rappresentano aspetti del sé che, nonostante possano essere visti come negativi o problematici esternamente, sono integrati e accettati internamente perché allineati con l'immagine di sé della persona. Questo legame tra l'immagine della carta e il concetto di egosintonico enfatizza la complessità e la soggettività della psicologia umana”.
Ma non finisce qui. La mia amica propone un nuovo nesso: “sì e poi ho pensato che forse tappano i buchi che creano”.
E la nuova risposta del programma:
“Ah, questa è un'interpretazione davvero affascinante! L'idea che le spade possano allo stesso tempo creare dei buchi e poi tapparli potrebbe rappresentare un meccanismo di difesa egosintonico. In termini psicologici, potrebbe simboleggiare come le persone possano sviluppare certi comportamenti o tratti che, sebbene problematici o distruttivi, servono allo stesso tempo a proteggere l'individuo da dolori o problemi interiori più profondi.
Questo concetto si applica bene a situazioni in cui una persona potrebbe mantenere comportamenti disfunzionali perché, in qualche modo, questi comportamenti "riparano" o gestiscono altre difficoltà psicologiche o emotive che non sono ancora pronte per essere affrontate apertamente. Quindi, le spade piantate nella barca non solo rappresentano una minaccia alla stabilità e alla sicurezza ma anche una necessaria forma di autotutela, almeno temporaneamente.
Questa doppia funzione può riflettere il complesso equilibrio tra autoconservazione e autodistruzione che spesso si trova nella psicologia umana, dove ciò che ci danneggia può anche essere ciò che ci protegge.”
A differenza della versione precedente, ChatGPT 4.0 mostra capacità interpretative molto più avanzate, in grado di utilizzare gli elementi del contesto per poter fornire una risposta non solo aderente alle informazioni possedute, ma adattabile a nuove informazioni e soprattutto a creare relazioni sofisticate fra i concetti.
La mia amica mi spiega dal punto di vista tecnico come ciò sia possibile. GPT 4.0 - come la versione precedente d’altronde, di cui il 4.0 è un’evoluzione - si avvale di un modello “transformer”, cioè di una rete neurale che può apprendere il significato di un dato, mappando le relazioni che intercorrono tra esso e il suo contesto (gli altri dati, appartenenti all’insieme con cui è alimentato il modello). Questo modello fa riferimento a una branca innovativa di tecniche matematiche, dette tecniche dell’attention o self-attention, tramite le quali è possibile emulare l’attenzione cognitiva umana. Le tecniche dell’attenzione attribuiscono, tramite un sistema di pesi flessibili, minore o maggiore importanza ai dati in ingresso, a seconda del contesto in cui si trovano, permettendo anche uno spostamento del focus qualora sia reso necessario dall’evoluzione del contesto del dato.
In altre parole, GPT 4.0 utilizza i dati di contesto proprio come fa la mente umana. Crea nessi fino a pochi mesi fa impensabili. Non solo continua ad apprendere nozioni, ma comincia a creare correlazioni tra elementi contestuali, fornendo risposte estremamente sofisticate.
Se state provando una sensazione apocalittica da fine dell’umano (o magari una versione più integrata da transumanesimo più confortante), vi comprendo. Sembrerebbe ormai prossimo il momento in cui i modelli artificiali riusciranno a sostituire completamente la mente umana.
Tuttavia, c’è ancora un elemento su cui va posta l’attenzione. GPT è in grado di dare risposte estremamente sensibili e adatte al contesto, ma è ancora la mente umana a porre domande. Quello che in gergo si chiama prompt, cioè la definizione del problema, il suggerimento iniziale da cui partire per elaborare.
Questo pone infiniti quesiti sul ruolo della psicologia come professione, ma anche sulla psicologia umana più in generale.
Riusciremo a dare il giusto valore alla capacità umana di porre domande e creare nessi ancor prima che l’elaborazione sia avviata? Non sarà proprio il merito di queste domande (quali porre, come porle, in relazione a cosa) il più grande tema etico dell’immediato futuro?