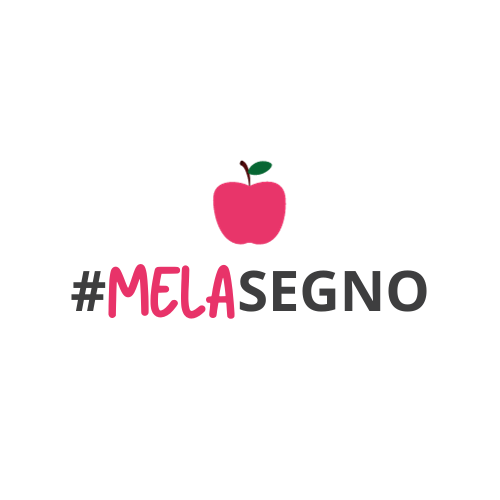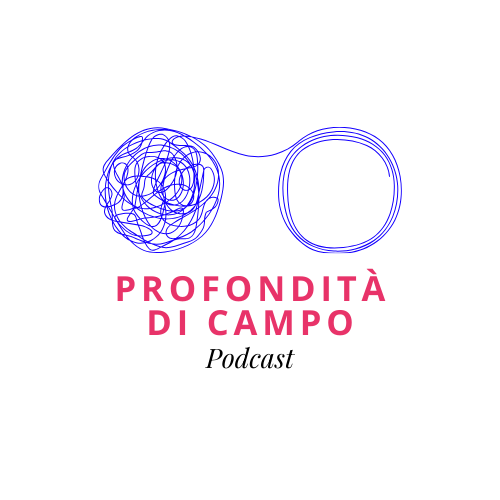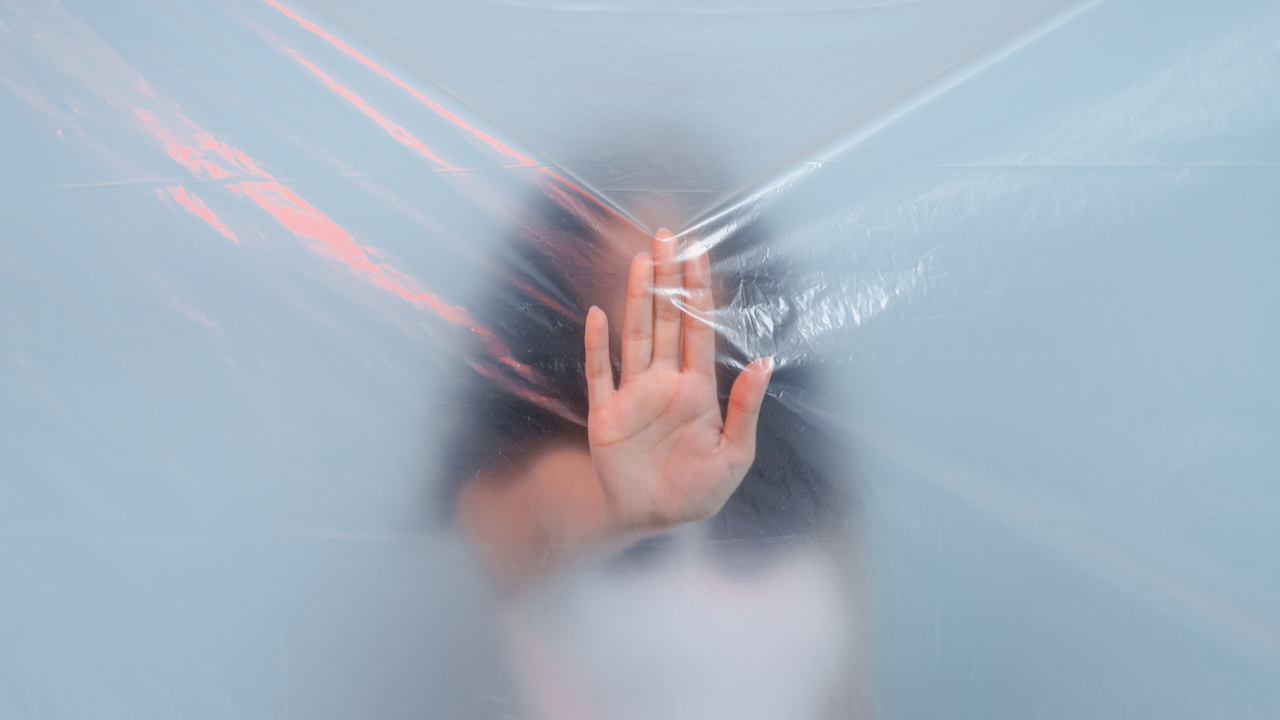Cristina è una ragazza di 32 anni, assidua frequentatrice del Centro di Salute Mentale della ASL territoriale di un quartiere romano, a cui si rivolge ormai da tempo per i suoi problemi psichici.
Durante una delle sue visite, viene invitata da uno specializzando a partecipare a un programma di valutazione della qualità del servizio sanitario, che consiste nella somministrazione di un questionario volto a verificare il giudizio dei pazienti rispetto al servizio offerto, all’accoglienza del personale sanitario, alla pulizia degli ambienti.
Cristina accetta volentieri, risponde a tutte le domande e accoglie con piacere la proposta dello specializzando di appuntarsi il suo recapito telefonico, nel caso in cui avesse bisogno di ricevere ulteriori delucidazioni sul programma.
Dopo poche ore, Cristina chiama lo specializzando, ma il suo atteggiamento è completamente cambiato. La donna è molto arrabbiata, è convinta che i suoi dati saranno utilizzati in modo inopportuno, si sente minacciata dal Sistema Sanitario, convinta che la vogliano controllare. Lo specializzando prova a rassicurarla, dicendole che i dati saranno trattati in forma completamente anonima, ma l’informazione non convince Cristina. La telefonata si chiude con minacce di denuncia da parte della paziente del CSM, che avvisa che sarebbe venuta in sede il giorno successivo.
Il giorno seguente, Cristina si presenta alla ASL con una torta di compleanno. Saluta il personale sanitario calorosamente e, rivolgendosi a tutti, dice: “oggi è il mio compleanno e voi siete la mia famiglia”. Guarda lo specializzando insieme agli altri operatori e si avvicina scusandosi per quanto avvenuto il giorno precedente e dichiarando che è affetta da un disturbo paranoide.
Il vissuto di Cristina oscilla fra due poli opposti, che descrivono il modo in cui la donna percepisce il contesto del CSM. Sono categorie primitive e totalizzanti con cui le relazioni sociali vengono interpretate: amico-nemico.
Cristina considera il CSM un contesto amico, sicuro, che è vissuto come familiare e di cui ci si può fidare. Ciò che le viene inizialmente proposto dal contesto (partecipare ad un questionario) è accolto con benevolenza, proprio perché proveniente dalla “famiglia”.
Tuttavia, lo specializzando che Cristina incontra è un estraneo, mai visto in precedenza, che si presenta come elemento esterno che conduce la ricerca per conto di un’istituzione, l’Istituto Superiore di Sanità. È questa estraneità che Cristina riconduce poco dopo al nemico, cioè al vissuto di essersi fidata di qualcuno di cui non ci si può fidare, perché ignoto e non appartenente (almeno non finora) al contesto familiare-sanitario. La sua reazione manifesta un vissuto persecutorio: l’estraneo, rappresentato come nemico, ha cattive intenzioni, vuole controllarla e vuole usarla. Cristina, tuttavia, ha fatto quello che doveva: dirgliene quattro, ribellarsi all’autorità, minacciare la denuncia.
Il giorno successivo, Cristina può tornare a percepire il contesto del CSM come amico, portando una torta, che è assieme mezzo di condivisione e dono riparativo. Lo specializzando, integrato ora nell’insieme del personale sanitario, non è più una minaccia e può diventare un confidente a cui dichiarare quale sia il suo “disturbo”, facendosi così conoscere attraverso il linguaggio condiviso della psichiatria, in quella che sente a tutti gli effetti “una famiglia”.
La storia di Cristina ci racconta di una categoria molto in voga anni fa, quella della paranoia, che negli ultimi decenni sembra essere meno utilizzata. La stessa psichiatria parla raramente di paranoia - concetto ampio ed entrato a far parte del lessico comune con un’accezione sprezzante (“smettila di farti le paranoie!”) - preferendo la dicitura disturbo delirante di tipo persecutorio.
Ciò che a noi interessa, tuttavia, è notare che il termine paranoia ha risvolti meno sensazionalistici rispetto ad altre categorie diagnostiche, per motivi culturali.
La cultura contemporanea, infatti, propone costantemente l’idea che “fidarsi dell’estraneo” sia un pericolo da cui proteggersi in modo preventivo, finendo per identificare come francamente paranoico esclusivamente l’eccesso di elucubrazioni persecutorie, come ad esempio, le teorie del complotto che delineano un disegno segreto da parte del potere politico ed economico, al fine di soggiogare la popolazione.
In altre parole, la paranoia ha una connotazione quantitativa: quando la diffidenza è troppa, fondata su teorie arzigogolate e raffazzonate, allora possiamo chiamare in causa la paranoia.
Vediamo un altro esempio che racconta in che modo la nostra cultura percepisca l’estraneo come minaccia da cui difendersi.
Anna è una donna di 39 anni, con un figlio adolescente. Ha appena terminato un colloquio con le insegnanti della scuola del figlio e attende l’autobus alla fermata. Un uomo in macchina si ferma e le chiede se vuole un passaggio. Per Anna quell’uomo ha un volto familiare, probabilmente si tratta del padre di uno dei compagni del figlio, di cui non ricorda il nome. In ogni caso, il gesto dell’uomo le sembra cortese e accetta il passaggio. Durante il viaggio in macchina, l’uomo le fa delle avances piuttosto spinte, Anna rifiuta e chiede di scendere dall’auto. L’uomo sembra stizzito, mentre Anna è furiosa.
A sera, Anna racconta la vicenda alle amiche in un pub, cercando comprensione dei suoi vissuti. Per lei, l’uomo si è comportato in modo sgradevole e inappropriato, ma le amiche le danno risposte di ben altra natura: “se un uomo che non conosci ti offre un passaggio, è chiaro che voglia provarci con te, niente si fa per niente”. Oppure: “sei stata incosciente, quell’uomo avrebbe potuto violentarti!”.
La piega della conversazione volge verso la colpevolizzazione di Anna. Lei non ha agito in modo preventivo, non ha pensato come una brava donna dovrebbe pensare, cioè con diffidenza.
La cultura contemporanea è a tutti gli effetti una cultura della diffidenza. L’estraneo non è un ignoto da conoscere ed eventualmente valutare a seguito di tale conoscenza, quanto un nemico nei confronti del quale prendere le dovute precauzioni.
Chi di noi non si è mai sentito dire, magari alle poste o dentro un bar: “ormai non ti puoi più fidare di nessuno, caro mio!”?
Ciò che non viene quasi mai sottolineato è che se la diffidenza apparentemente ci difende da potenziali pericoli, essa è una modalità emozionale di vivere i rapporti sociali molto dispendiosa, perché richiede uno stato di allerta costante, che annulla le specificità del contesto, rappresentandolo come un unico e universale ambiente di lotta per la sopravvivenza.
In questo senso, ci viene in aiuto la definizione che Carli e Paniccia (2003) danno della diffidenza, una neo-emozione considerata la versione passiva del vissuto di controllo.
“La persona diffidente vive in uno stato di perenne allarme, legge in tutto quello che gli capita attorno segnali di pericolo, di ostilità, di disistima, di critica, di disapprovazione. Se ne difende con la convinzione che non ci si può fidare”.
Le persone non diffidenti vivono il rapporto con l’estraneità, con ciò che è sconosciuto, seguendo la logica per cui “tu sei amico, a meno che non mi dimostri di essere nemico”. Per poter diffidare dell’altro, l’altro deve fare qualcosa che ci deluda o ci minacci, come nell’esempio sopra riportato: Anna si accorge che non si può fidare solo dopo che l’uomo in macchina le rivela le sue intenzioni, facendole delle avances.
Questo modo di vivere la relazione può essere rappresentato anche con un esempio che riguarda i sistemi di allarme. Le nostre automobili sono pensate per avvisare che c’è un problema solo nel momento in cui esso si verifica. La spia del motore è di base spenta, si accende solo nel momento in cui qualcosa non va e occorre andare dal meccanico. Tutto va bene, a meno che non intervenga un imprevisto.
Le persone diffidenti vivono il rapporto con l’estraneità in modo capovolto: “tu sei un nemico, a meno che non mi dimostri di essere amico”. E’ il caso delle amiche di Anna al pub: ci si deve aspettare il peggio dagli sconosciuti, le possibili azioni negative devono essere preventivate ancor prima che si entri in relazione con l’estraneo.
È chiaro che in questa seconda ottica, la dimostrazione di essere amico non avviene una volta per tutte. L’estraneo deve dimostrare più volte le proprie buone intenzioni, perché il pericolo è sempre dietro l’angolo.
Restando sempre nell’ambito dei sistemi di allarme, in ambito militare la minaccia si esprime attraverso l’assenza di rumore. I congegni di sicurezza sono pensati per essere sempre accesi, lampeggianti, emettendo un suono che finisce per diventare il rumore di sottofondo della condizione di normalità. Soltanto quando essi si spengono segnalano un pericolo in essere per il quale è richiesto un intervento immediato.
I sistemi di allarme militari sono un’ottima metafora del funzionamento emozionale della persona diffidente. Lo stato di allarme è sempre acceso, non ci si può fidare di nessuno perché siamo in guerra. L’assenza di segnale di minaccia allora diventa intollerabile per il diffidente, che non crede realmente che l’altro possa avere buone intenzioni, certamente non in poco tempo. Deve dimostrarlo all’infinito e questa costante ricerca di rassicurazione rende i rapporti sociali (come ad esempio quelli sentimentali) insostenibili.
Se il senso comune da sempre sostiene che “fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”, la vera domanda che poniamo è: quanto costa, in termini emozionali, la sfiducia costante? La diffidenza è davvero funzionale a proteggere dalle minacce o piuttosto dall’angoscia di non avere controllo sull’altro e dunque dalla difficile necessità di conoscere l’altro per entrare con lui in relazione?