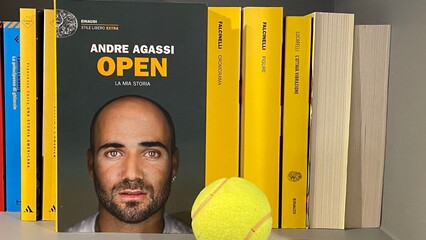Durante il discorso che tenne in occasione della cerimonia delle lauree al Kenyon college il 21 maggio 2005, David Foster Wallace esordì con un aneddoto:
“Ci sono due giovani pesci che nuotano uno vicino all’altro e incontrano un pesce più anziano che, nuotando in direzione opposta, fa loro un cenno di saluto e poi dice “Buongiorno ragazzi. Com’è l’acqua?” I due giovani pesci continuano a nuotare per un po’, e poi uno dei due guarda l’altro e gli chiede “ma cosa diavolo è l’acqua?”
La natura di questa domanda è stato uno dei nuclei fondativi dell’articolata opera di quello che è stato considerato tra i più grandi scrittori del post-modernismo americano.
La rassicurante, uterina tentazione ad affondare nell’incoscienza quotidiana, senza costantemente esercitare la disciplina di interrogarsi sugli oggetti verso i quali direzionare il pensiero, è stato in Wallace traccia inesauribile di preoccupazione.
Lo spunto narrativo di Una cosa divertente che non farò mai più (titolo dal quale è stato ingiustamente rimosso l’aggettivo “supposedly”, che restituisce quanto meno un dubbio sulla qualità dell’esperienza) è il reportage che viene commissionato all’autore sulle vacanze nelle navi da crociera di lusso. Vivendo in prima persona la vacanza, attraverso aneddoti che la sua voce ci consente di percepire nella loro grossolana assurdità, Wallace ci fa da autentico compagno di viaggio (non condiscendente, non paternalistico e non supponente - già, solo questo, di autentica grazia narrativa) nell’esplorazione della seducente promessa che sta alla base della crociera: liberare le persone dal peso della responsabilità di dover compiere delle scelte, senza tuttavia sentirsi in colpa rispetto a questa sospensione del volere.
Nel taccuino su cui annota le impressioni di viaggio, scrive: “Ogni giorno sono costretto a compiere una serie di scelte su cosa è bene o importante o divertente, e poi devo convivere con l'esclusione di tutte le altre possibilità che quelle scelte mi precludono. e comincio a capire che verrà un momento in cui le mie scelte si restringeranno e quindi le preclusioni si moltiplicheranno in maniera esponenziale finché arriverò a un qualche punto di qualche ramo di tutta la sontuosa complessità ramificata della vita in cui mi ritroverò rinchiuso e quasi incollato su un unico sentiero e il tempo mi lancerà a tutta velocità attraverso vari stadi di immobilismo e atrofia e decadenza finché non sprofonderò per tre volte, tante battaglie per niente, trascinato dal tempo. E' terribile.“
In questa riflessione c’è tutta intera l’incrinatura quasi impossibile a rintracciarsi nella luminosità dell’esperienza (sulla nave tutto è liscio, facile, splendente - dalle superfici dei sanitari al sorriso della equipaggio).
Perché, a ben guardare, il bisogno indotto non è mai soddisfatto. Ed il bambino viziato potenzialmente non esaurisce mai la sua richiesta. La domanda sul fondo, allora, rimane drammaticamente la domanda psicologica ed esistenziale sul senso.
Vivendo nell’ontologica e frammentata pervasività dell’offerta della società contemporanea, il rischio dell’alienazione e del solipsismo ha accompagnato Wallace con lo stesso ardore esistenziale di scrittori come Camus e Sartre, che in altra epoca si sono interrogati sul paradosso della scelta, nella ricerca estenuante di trovare un contrappunto all'horror vacui del vivere. Nella narrativa di Foster Wallace, questa ricerca è stata condotta nella trame della società capitalistica della fine degli anni ‘90, in cui la sovraesposizione al modello consumistico si traduce nella catalessi del bisogno indotto, nella dipendenza da soluzioni a portata di mano per recedere dal peso della coscienza.
Se c’è un invito diretto che Wallace fa con la sua opera, allora, è questo: non dimenticarsi dell’acqua. Ovvero, continuare ad osservare e interrogare la realtà, abbandonando psicologicamente quella che lui chiama “la configurazione di base”, cioè la prospettiva egocentrica dell’io, che progressivamente chiude gli orizzonti vitali in una rete di pregiudizi, provando invece a stare nel mondo con compassione non retorica, con autentica empatia.
“E vi dico anche quale dovrebbe essere l’obiettivo reale su cui si dovrebbe fondare la vostra educazione umanistica: come evitare di passare la vostra confortevole, prosperosa, rispettabile vita adulta, come dei morti, incoscienti, schiavi delle vostre teste e della vostra solita configurazione di base per cui “in ogni momento” siete unicamente, completamente, imperiosamente soli.”