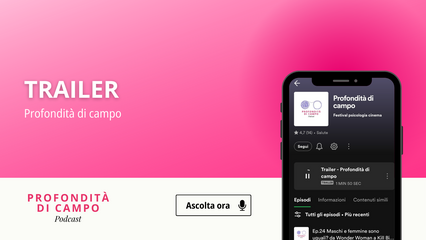E’ notte, ho appena terminato di vedere la stupenda opera visionaria di Kaufman, I’m thinking of ending things, ma sono ancora in pieno binge watching, così decido di scorrere le proposte consigliate da Netflix. Mi imbatto in Transfert, film italiano ormai non più recente (2018), che parla di psicoterapia. E’ perfetto, penso. Posso sedermi comodo e giudicare tutti gli stereotipi che sulla psicoterapia saranno certamente narrati dal regista, con l’occhio bramoso di chi non vede l’ora di assalire la preda.
Solitamente agli psicologi e psicoterapeuti non piacciono le opere cinematografiche che li rappresentano. Immagino che la stessa cosa valga anche per altre professioni, medici, avvocati, ingegneri. I pregiudizi sulla professione sono sempre dietro l’angolo e il più delle volte la complessità della relazione terapeutica è appiattita sia per motivi narrativi, sia per l’intrusione dei codici del senso comune.
L’inizio di Transfert, opera prima di Massimiliano Russo, conferma ampiamente le mie aspettative. Nelle prime battute, il film si limita ad essere didascalico. Il protagonista è Stefano, psicoterapeuta alle prime armi, che ha un passato traumatico. Sua madre, il cui equilibrio psichico è chiaramente compromesso, lo cresce instillando in lui, più che il desiderio, l’obbligo a diventare uno psicoterapeuta per salvarla dalla sua condizione. Questo obbligo è rappresentato in una scena straziante, che alla lunga si rivelerà l’unica poco efficace e credibile di tutto il film: la madre in preda ad una crisi abbraccia il suo bambino, pregandolo di diventare da adulto un terapeuta per aiutarla.
Nella realtà, è veramente raro che un rapporto di inversione di ruoli tra madre e figlio, anche quando porta alla scelta di diventare psicologo da parte di quest’ultimo, si palesi in modo così esplicito. Le relazioni psicotiche e fusionali hanno un linguaggio molto più ambiguo. Il bisogno di cure che il genitore esprime al figlio passa spesso attraverso un piano non verbale e simbolico, la cui decodifica è molto complessa, soprattutto in età infantile.
Le didascalie, tuttavia, si susseguono. Un paziente molto più grande di Stefano si lamenta della sua giovane età; in una scena, Stefano si dilunga a spiegare il segreto professionale cui sono vincolati i terapeuti; una coppia domanda a Stefano se avesse figli, facendo intuire che, non avendoli, non possa davvero capire cosa significhi provare paura per il proprio figlio.
Agli occhi di uno psicoterapeuta, la sceneggiatura sembra scritta da un profano che vuole spiegare allo spettatore cosa sia la psicoterapia e quali siano i pregiudizi più frequenti.
L’acme è raggiunto quando Stefano decide di prendere in cura separatamente due pazienti, sorelle, violando i limiti deontologici della professione, che invece sconsigliano caldamente di trattare contemporaneamente due parenti in percorsi distinti. Ti pareva, penso. Prima le didascalie, poi le regole che vengono trasfigurate per esigenze narrative.
Se adesso state pensando che il film sia un completo fallimento, sappiate che vi sbagliate di grosso. Russo non sta comunicando solo agli spettatori profani, ma agli stessi psicoterapeuti.
Il finale, infatti, ribalta completamente tutto quello che lo spettatore sin qui aveva ipotizzato. Non lo fa con un solo cambio di prospettiva, ma con un doppio colpo di scena, che si dipana vertiginosamente, portando chi guarda a sospendere qualsiasi giudizio.
Solo a racconto concluso si capiscono le intenzioni del regista. Tutte quelle didascalie iniziali non servivano a giocare con gli stereotipi che le persone hanno sulla terapia, ma con gli stereotipi che hanno gli psicoterapeuti nei confronti di chi parla di psicoterapia dall’esterno. Russo conosce bene questi stereotipi, li spinge sino al parossismo per poi sovvertire le regole del gioco.
Così, se per tutto il film lo spettatore (che sia psicoterapeuta o meno) è convinto che il tema cardine sia rispondere alla domanda: quali traumi infantili spingono alcune persone a diventare terapeuti?, nel finale si comprende che il vero tema riguarda il rapporto tra psicopatologia e psicoterapia.
Qual è il confine fra la malattia e la cura? C’è sempre un momento nella crescita del futuro psicoterapeuta, nel quale il rischio di passare dall’altra parte e diventare un paziente è reale? Quel confine, poi, è davvero oltrepassato una volta per tutte, o resta un limes precario che accompagna la vita di chi ha vissuto un trauma?
L’aspetto decisamente interessante del film è forse racchiuso nella frase finale pronunciata dallo Stefano-bambino: “mamma, mi piace la psicoterapia, ma non voglio diventare uno psicoterapeuta. Voglio diventare un paziente”. Pazienti o psicoterapeuti, dunque, si diventa, la scelta non è obbligata.