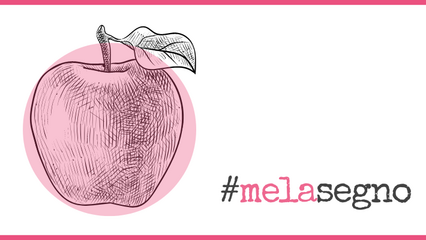“Libera nos a malo”
La storia del senso di colpa nella cultura occidentale è strettamente connessa alla storia del pensiero cristiano, non tanto alla riflessione teologica più colta, quanto all’elaborazione del dogma evangelico che il senso comune ha proposto nel corso dei secoli.
Il senso di colpa è un’emozione radicata nella cristianità ed è soprattutto nella confessione che emerge come deterrente che permette l’espiazione dei peccati, intraprendendo così la via della redenzione. Sentirsi in colpa per le proprie azioni è un movente sicuro per aderire alle norme e garantire - prima ancora che l’accesso al Regno dei Cieli - l’appartenenza al gruppo sociale.
Il senso di colpa, infatti, è un’emozione sociale per definizione. Permette di riflettere su quanto si è agito con gli altri e rimediare, soprattutto se consideriamo che il Cristianesimo è una delle religioni più incentrate sul senso relazionale delle azioni individuali. Il rapporto con Dio è prima di tutto rapporto con la comunità dei cristiani e la dimensione pubblica è primaria rispetto all’elaborazione privata della fede.
Tuttavia, analizzando la più importante preghiera della cristianità, il Pater Nostrum, già presente nei Vangeli di Matteo e Luca, emerge un aspetto interessante. I primi cristiani non parlavano tanto di colpa, quanto di tentazione. “Non indurci in tentazione”, poi modificato negli ultimi decenni in “non abbandonarci alla tentazione”, giacché Dio non è rappresentato come l’origine di essa, quanto come guida in grado di “liberarci dal Male”. La tentazione è opera del Maligno, sempre presente. Se si accetta che il Male esiste, non c’è colpa nel cedere alla tentazione, purché Dio ci protegga dall’abbandono completo. La vera lotta non è contro sé stessi e le proprie colpe, ma contro un male altro da cui si può essere liberati.
Questo esempio evangelico è utile nel comprendere il ruolo sociale del credo cristiano, che nella cultura individualista odierna sembra essere sempre più sfumato.
L’individualità dell’uomo contemporaneo si barcamena tra un senso di impotenza frustrante (basti pensare al mondo del lavoro e dei rapporti d’amore, nei quali i limiti sono percepiti come aggressione alle proprie fantasie di autodeterminazione infinita) e un senso di onnipotenza inebriante (il motto “diventa ciò che desideri” apre a infinite possibilità di realizzazione, spesso decontestualizzate dalla realtà materiale e dai confini relazionali necessari a qualsiasi tipo di incontro con l’altro).
In questo contesto, la colpa non è più un’emozione che connette l’individuo al contesto e alle sue regole, quanto un sentimento autoriferito, che racconta come viviamo il rapporto con i limiti nella nostra cultura.
Da qualche anno, un nuovo termine si è affacciato tra la pletora di nuovi concetti proposti dal neo-liberismo, quello del Niksen, definito come “l’arte di non far nulla senza senso di colpa”. Termine nato in Olanda, ironicamente (o forse nemmeno troppo) uno dei paesi che hanno diffuso la cultura del capitalismo, incentrata sull’iper-produttività. Il concetto, infatti, poco si adatta al vissuto degli olandesi:
“Il fatto è che non ha niente a che vedere con la nostra cultura. Al contrario, siamo calvinisti e ci diciamo sempre di lavorare di più. Siamo cresciuti nella convinzione che dobbiamo sempre essere utili e disponibili. Il niksen è il diavolo da cui non viene nulla di buono”.
Altro aspetto interessante è che una volta inventato il termine, ci si affretta a legittimarlo, in accordo alle categorie che condividiamo. Non significa “non fare nulla”, ma non porsi scopi per le proprie azioni. In pratica, qualcosa si fa sempre anche nei momenti di ozio, l’importante è che non abbia obiettivi prestabiliti.
Pensiamo alle grandi lotte del Novecento per i diritti sul lavoro. Gli individui si sentivano parte di forze collettive (gli operai, gli impiegati, gli imprenditori-padroni) e la possibilità di avere tempo improduttivo, o produttivo ma al di fuori del contesto di lavoro, era percepita come un diritto sociale, una conquista da conservare e proteggere attraverso il conflitto o il compromesso. Il nemico era lo sfruttamento e, per quanto distanti ideologicamente, tanto i padroni che gli sfruttati, condividevano e comprendevano il linguaggio del conflitto sociale.
Oggi quel conflitto si è non solo individualizzato, ma è spostato dal piano delle relazioni al piano del vissuto personale.
La lotta non è contro un mondo che si è appropriato di tutti gli spazi e i tempi non lavorativi, ma contro il senso di colpa provato a non essere attivi, a non “fare qualcosa”. Sospendere le attività, passare il tempo senza prodotto è vissuto con angoscia.
Il Niksen, dunque, diventa uno strumento di legittimazione del “dolce far nulla”, a testimonianza del bisogno che qualcuno ci autorizzi all’improduttività.
Se un tempo la richiesta a Dio era “liberaci dal male”, oggi la richiesta al mercato divinizzato è “liberaci dal senso di colpa”. Un vissuto spiacevole che non può essere pensato, ma deve essere eliminato in modo onnipotente, nel momento in cui scegliamo di non fare nulla.