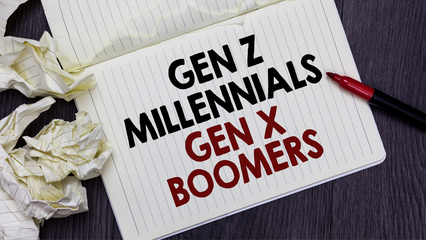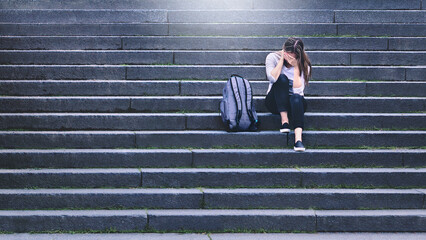Quando sentiamo parlare di comfort food, di cibo consolatorio, ci torna alla mente l’immagine di Bridget Jones che si abbuffa sul letto di gelato industriale, avvolta dal piumone e nella più completa solitudine. L’immaginario costruito attorno agli effetti ansiolitici e antidepressivi del cibo è costellato di cioccolata e serotonina, di aree cerebrali che si attivano, di ingiunzioni mediche ad essere parsimoniosi, di vuoti da colmare con alimenti più o meno sani.
Una visione individualista e medicalizzata che scalfisce soltanto la superficie del valore simbolico-emozionale che il cibo riveste nelle nostre vite.
Il cibo nella Storia è stato strumento di potere e di distinzione culturale. La cucina dell’impero romano, ad esempio, era una cucina sintetica. In essa prevaleva il principio gestaltico del tutto come qualcosa di più della semplice sovrapposizione delle parti. Nel Satyricon felliniano vengono immortalate immense portate di scrofe ripiene di crostacei e grano, innaffiate di vino e cosparse di pepe. Oggi ci apparirebbero come un miscuglio indifferenziato, ma all’epoca la mescolanza rispondeva ad un preciso significato simbolico, rappresentare l’estensione dell’Impero direttamente sulla tavola. Così il maiale laziale si univa ai gamberi delle coste anatoliche, al grano egiziano, al vino iberico e al pepe mediorientale e indiano, per incarnare attraverso il cibo il potere di Roma sul mondo.
Il principio sintetico dura fino alla fine del ‘700, quando l’Impero britannico, che ha il monopolio del mercato delle spezie, pregiatissimo simbolo di dominazione oceanica e coloniale, comincia ad essere osteggiato dall’impero francese. La Francia, non potendo contare sulla materia prima di lusso, comincia a diffondere un secondo principio gastronomico, quello analitico. Non è più la ricchezza degli ingredienti a dare lustro al piatto, ma la sapienza artigianale dello chef, in grado di esaltare il sapore differenziato del singolo elemento.
Al valore della materia prima, si contrappone il potere della tecnica e da lì origina la tradizione francese dei saucier e dei maestri culinari.
Potremmo dilungarci sulle origini del cornetto come simbolo di rivincita cristiana sul pericolo turco dopo l’assedio di Vienna del 1683 (non a caso la sua forma è quella della mezzaluna), oppure sul ruolo che la sachertorte ebbe nel conferire agli Asburgo il primato di dettare la moda del tempo, ma non è questa la sede. D’altronde non è un caso se, quando pensiamo alle più grandi multinazionali, ci vengono in mente McDonald’s o la Coca-Cola.
Il cibo tuttavia non è solo un simbolo politico, ma assume una funzione autobiografica anche nel contesto privato. Senza scomodare le madeleine di Proust, la letteratura si è spesso occupata del cibo come memoria. Muriel Barbery, prima del successo internazionale de L’eleganza del riccio, scrisse sul tema il bellissimo Estasi culinarie, nel quale un critico gastronomico sul letto di morte cerca di rievocare il “sapore perfetto”, ripercorrendo così la sua intera vita punteggiata dai ricordi associati a diverse pietanze.
Anche in casa nostra, Simonetta Agnello Hornby in un’intervista ricordava come il gusto sia l’ultimo senso ad abbandonare le persone più anziane. Mentre la vista, l’olfatto e l’udito perdono gradualmente vigore con il passare del tempo, il gusto ci riconnette con le nostre esperienze pregresse, fungendo da collettore e organizzatore esistenziale.
E’ questo il motivo per cui spesso le persone più anziane faticano a cambiare le proprie abitudini alimentari anche di fronte a patologie croniche e invalidanti. Rinunciare al gusto è in parte rinunciare alla propria storia.
Il cibo è un profondo attivatore identitario ed ha un ruolo essenziale nella costruzione e nella rappresentazione del Sé. Le pietanze che amiamo raccontano prima di tutto le esperienze che abbiamo avuto ed il legame simbolico con esse, le emozioni che proviamo a e abbiamo provato, che non sempre sono del tutto coscienti. A volte il nesso è radicato nel nostro inconscio e non sappiamo bene perché ci piaccia proprio quel cibo, mentre quell’altro ci disgusti.
Provate a chiedere ad un amico quali cibi preferisca e per quali motivi e vi risponderà che “lo fanno stare bene”, “hanno un buon sapore”, “mi consolano”, “mi rendono felice”. Provate poi a chiedergli quali ricordi associ a quelle pietanze e vedrete che la solitudine si popolerà di relazioni. Così nel racconto emergeranno cene di famiglia, il rapporto con i nonni, scene di accudimento, esperienze amicali e sentimentali. Il ricordo è il ponte che permette di risolvere il dramma di Bridget Jones, riscoprendo la condivisione sociale come il vero fattore che rende il cibo un conforto.