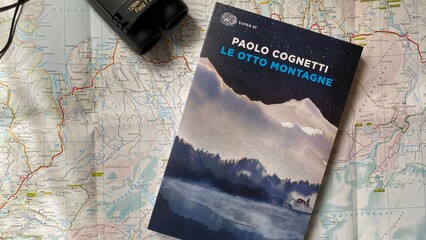In questi giorni, come la maggior parte delle persone, trascorro più tempo del solito sui social network. Mi sembrano uno specchio piuttosto fedele delle dimensioni emotive più immediate che la situazione dell’emergenza sta attivando. Ho visto, sulle bacheche nei miei conoscenti, molte iniziative per utilizzare creativamente il tempo della forzata quarantena: gruppi che si costituiscono per imparare a costruire mascherine, cacce al tesoro a puntate, suggerimenti su quale migliore musica, migliore lettura, migliore filmografia scegliere per accompagnare questo nuovo tempo di attesa. Da questo terreno tutto sommato morbido ho visto spuntare come lance avvelenate strali e invettive riguardo ad un unico argomento: ancor più che sulle scelte politiche, o addirittura sulla preoccupazione dell’andamento del contagio e sugli scenari del più prossimo futuro, i toni si sono fatti straordinariamente alti sulla questione del restare a casa, anzi del non restarci. Detto in altri termini, sto parlando della questione dei runner (vero è proprio topos di questi giorni), che estensivamente comprende chi esce senza mascherina, chi porta il cane fuori, chi compra le sigarette.
Nelle disposizioni dei decreti che si sono susseguiti nei giorni ci sono state indicazioni piuttosto precise sui comportamenti da mantenere. Sono stati approntati moduli di autocertificazione per dichiarare i moventi dei movimenti (caso quasi unico in Europa e nel mondo, quello delle autocertificazioni). Insomma, c’è stata un’indicazione normativa atta a disciplinare queste condotte. Ma, su questo punto, la norma giuridica non è riuscita a saturare e contenere la dimensione affettiva e, da lì, le opinioni e i comportamenti delle persone. Abbiamo cioè assistito ad una polarizzazione dell’attribuzione di significato a determinate azioni, per cui chi usciva di casa per camminare (o correre) è stato tacciato ipso facto di essere un trasgressore, un provocatore, un irresponsabile. Irresponsabile rispetto a cosa? Sembra un paradosso, laddove la norma stabiliva quale fosse il comportamento responsabile. Viene da dedurre che per larga parte dell’opinione pubblica che si è agitata su questo punto, sia proprio il concetto di responsabilità a essere minaccioso. Troppo margine all’arbitrio. Ed evidentemente troppa poca fiducia che l’individuo sappia regolarsi.
Gli studi sui comportamenti prosociali (cioè di cooperazione e fiducia nei confronti dell’altro) ci dicono che la rivalità tra gruppi aumenta quando il contesto sociale è più instabile e quando le persone non hanno avuto l’occasione di sviluppare in precedenza un’interazione reciproca.
Traducendo, in un momento di attivazione di grandi angosce collettive, chi ostenta un atteggiamento di autodeterminazione, anche rimanendo nel perimetro del consentito, viene investito di pesanti proiezioni di gruppo e considerato come responsabile del fallimento delle strategie di difesa e sopravvivenza del gruppo stesso. La polarizzazione di questa visione può assumere aspetti molto violenti: chi esce di casa, chi non incarna con il suo comportamento l’adesione alla visione difensiva del gruppo (che si definisce nella retorica del sacrificio) non ha attenuanti, non gode della possibilità di articolare, mostrare, spiegare, individualizzare il comportamento: sta facendo una cosa che per la morale collettiva non si fa, e basta. A chi viene identificato come trasgressore si attribuisce tutta la filiera della colpa: non avere rispetto per gli altri, non curarsi dei medici e di tutto il personale sanitario che sta lavorando indefessamente e coraggiosamente, non curarsi dei morti. Si mobilitano i più elementari processi di controllo, accusa, discredito, odio.
Quello a cui si assiste è dunque una straordinaria riduzione di complessità, in cui il singolo individuo è chiamato ad aderire, per far parte del gruppo, alla costellazione completa dei comportamenti che per la collettività vengono considerati adeguati e giusti.
La paura, che è l’origine comprensibile di queste forme di proiezione, pretende l’individuazione di un colpevole, di un oggetto su cui riversare la sua vibrazione d’angoscia. Ma le derive irrazionali di questo movimento sono potenzialmente ancora più temibili, sul piano sociale della convivenza e della cooperazione. Ce lo insegnano le molteplici forme dell’intolleranza nei confronti del “diverso” di turno. E se i risultati sperati non arrivano, l’intero impianto collettivo, con le sue regole d’emergenza, non può che acuire i suoi ingredienti irrazionali. Cerchiamo di fare attenzione, la strada che stiamo percorrendo sembra ancora lunga.